
Medi terraneo
La lettura dei versi di Antonella Doria rimanda a un presupposto: una dichiarazione di poetica che non può non fare i conti con la storia, quella scritta in maiuscolo. Storia che è frattura, iato e, contemporaneamente, impossibilità di ricomposizione armonica: qualcosa si è rotto nell’equilibrio legato al rapporto io-cosmo e non esistono soluzioni all’abisso che si è generato. Medi terraneo è la rappresentazione scenica di tale abisso. Forse siamo di fronte a un poemetto ad una voce, una sorta di monologo pensato per una recitazione dolorosa; la sensazione è quella di assistere a un lamento di tipo sciamanico: il testo si articola in un canto senza limiti di continuità, destinato ad essere ascoltato e vissuto con l’ambiguità del miraggio. Medi terraneo, ovvero spazio simbolico, confine, limite incerto tra terra e deserto, tra mare e cielo: qui avviene l’incontro-scontro tra uomo e storia, qui occidente e oriente si compenetrano e sopravvivono più per degrado, decomposizione, virus. Medi terraneo, luogo-non luogo in cui il tempo non ha denotazione, il principio maschile e quello femminile si intrecciano fino a incatenarsi, alla ricerca di una logica,
un senso di esistenza. Tale tragedia, tutta nostra, è evocata e nascosta dal punto di vista delle voci che agiscono dall’interno del tessuto poetico sviluppando un percorso corrosivo, l’idea del non ritorno. Per tutti valga l’esempio di Calipso – certo, quella trasfigurata da Pascoli mentre accoglie Odisseo morente metafora, proprio lei che nasconde la morte donando l’immortalità, dell’ineluttabilità del Fato, della condizione umana. Medi terraneo è dunque questo: accettazione del non essere e, contemporaneamente, del rimpianto inconscio di essere stati altro. In tale ottica incrociano sfaldandosi sistemi religiosi, nord e sud del mondo, tecnologia, riti ancestrali. E urlano, quasi a farsi male. Poi sopravviene il silenzio, la saggezza del deserto e dell’orizzonte che tutto parifica, tutto annulla: città, volti, storie, civiltà. Ciò che sopravvive è il lamento-canto-poesia delle donne: donne-in-nero ma anche dee-madri, donne-onde che vanno e vengono come il mare che fagocita, inghiotte; donne-saggezza, che intrecciano canti e impastano pane, donne-dee che cercano amore per dare la vita. Il viaggio da intraprendere è allora diretto al passato, alla ricomposizione di una realtà aliena da principi religiosi, da tecnologie vuote, da bombe intelligenti: un mondo arcaico, dove il principio femminile risulta evidente e prioritario. Medi terraneo, quindi, è luogo centripeto e centrifugo: qui tutto giunge, accade, si sfa; da qui tutto fugge, migra, cambia. E si sfibrano le voci dei beduini, dei canti religiosi, degli occhi senza volto che sfidano il deserto per giungere alla costa, da dove rimpiangono la terra abbandonata. Qui muove fino a scomparire Ulisse; qui naufraga accecata dallo scirocco Menmòsyne. Non esiste approdo che sia saldo, solo il lento divenire del mare che baratta le sue onde e le bugie dell’Occidente, la voce senza timbro di un dio e la serpe che si annida fra gli ulivi; e tutto perde innocenza. Solo l’accento di un canto, di un respiro, tenta di portare armonia, Poi il mare. Mare che è deserto e nuvola, mare che non ha più confini. Mare-utero da dove non uscire, o meglio dove tornare: medi terranea riva/ luogo primordiale del ritorno. Anche da un punto di vista stilistico, il testo rinvia ad una frattura insanabile; la parola diventa mezzo di cesura, separazione, iato. E il verso spesso si frammenta in emistichi dissonanti e dissacranti. Anzi, la parola si fa essa stessa verso, quasi ad implodere, come se nulla resistesse alla sua forza evocativa. Lo spessore ritmico del poemetto diventa così testo, strumento di analisi e denuncia: Antonella Doria spezza e ricompone a suo piacimento il tessuto narrativo violandone la sintassi. L’impatto con la materia poetica si fa quasi devastante, nella contrapposizione tra due registri: il primo, quello della storia che accade, veloce, frammentato, addirittura nervoso; l’altro, di respiro cosmico, atemporale, legato ai rituali femminili, alla presenza salvifica di una dea-madre, che tenta di ricomporre un’unità. Al centro, nell’ombelico del mondo, la terra di nessuno, il punto di contatto e di non ritorno. E la violazione dell’equilibrio, del patto con un dio-uomo oscillante tra Antico e Nuovo Testamento, tra Corano e riti orfici, principio maschile e seme di una civiltà orfana di dei.
Versato un piccolo tributo, nel titolo, al respiro delle neoavanguardie del secondo ‘900, la consentaneità con tale provenienza, subito si stempera fino ad un sobrio allontanamento. Si tratta di un poemetto che vuole spezzare una lancia per l’unitarietà del senso, scandito in sette parti.
Più che ai giorni della creazione, però, il rinvio, dopo una debita moltiplicazione per quattro, è rivolto alla luna ed alla vita femminile: proprio a questa infatti sono dedicati gli ultimi tre versi di ciascuno dei capitoletti. C’è una breve ouverture d’inquadramento generale, dove la confusione desertica è quella dell’infinito asfalto del mare mediterraneo, in cui i corpi viventi hanno incorporato una direzione che, se si è fortunati, anziché in pasto ai pesci ti fa trapassare da una tragedia a un’altra, difficile dire se migliore o peggiore. A fare da guida, la “sibillina fede follia” che non sembra promettere particolari rasserenamenti. Il risultato è che si è tutti nomadi insieme ad un’unica cena sotto le stelle che insegna l’attesa, spazio vuoto, simile ma opposto a quello del temporeggiare. E le donne con il braciere portano l’acqua e la parola necessarie. Il montaggio procede e si distende, la storia si dipana in un catino di rose e di topi, dove sono sempre pronte braccia avviluppanti e storie. È un’epica modica, di passaggio, con i suoi riferimenti mitologici a Circe, Calipso o Mnemòsine, madre delle Muse. Ma subito si ripiomba nella cronaca-storia come per quei disgraziati soldati iracheni che erano corsi ad arrendersi, per una svista, anziché ad un’armata nemica all’armata Brancaleone di una troupe televisiva a sua volta spaurita e tremebonda, o il tuffo olimpionico dal moncone del ponte distrutto di Mostar. Tutto si muove “in un perfetto errore geografico” verso una ricomposizione o forse definitivo sfacelo e in fondo a tutto donne sempre / promettono notti prima / dell’alba. Il linguaggio è magro e non indugia, si lascia radunare velocemente come un filo intorno al gomitolo, con le sue cicatrici in arabo o in curdo; è una storia vista da un occhio sospeso che guarda verso un sud che ribolle da un nord che parla ancora ligure e bergamasco. E il ritmo non viene mai meno; la vigilanza metrica sull’assunto, consente all’azione di snodarsi senza impantanamenti in un’economia della curiosità che mai reca con sé la tentazione della disattenzione. Anzi, convoca complicemente verso la discrezione dell’appartenenza all’incalzare dei capitoletti in naturale vicendevole propulsione, percorrendo un lungo ponte che non c’è.
a mio padre
Angelo
mio primo poeta
16
17
Nel mare il pericolo è
l’abisso
Fernando Pessoa
*
( migranti)
Io abito i deserti
senza alberi e senza ombre
da lontano le dune
aride i cespugli assetati
e i mari…
i mari dai miraggi danzanti
medi terraneo corpo
eterno sempre frattale
mare di febbre ovunque
d’acque culla rive
di sale lega avvolge
fragile forte
terra tribale
annega
si fondono
confondono luoghi
liquide città finestre
d’orizzonte diverse tutte
odorano rena salmastro
sapidi volti isole
di pietra dove il piede
si poggia
s’insinua
striscia mano stretta
pellealcorpo ponte
su altra riva aperta
terra cerchio rimuove
cancella catena
18
ambigua
riva penetra perenne incontro sfida
perpetua rituale
inarrestabile
lingua mare sconfinato pensiero
precarie
onde inquietudini puntidivista muove segni sedimenti
immateriali contaminati campi radici
visibili invisibili
giacimenti ventre mare
19
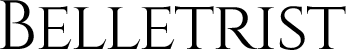
Lascia un commento