
Metro Pólis
Metro polis lo dice chiaramente, nel suo titolo: si tratta di una poesia della città. La città (la polis) sarà messa in metro, verrà, cioè, tradotta in versificazione, “riversata” in poesia. Siamo su un nodo fondamentale della Modernità: la poesia non può che essere assolutamente metropolitana. E a questa “metropoli-poièsi”, a questa città-in-versi, corrisponderà, quindi, una poesia che ha per oggetto enti collettivi e che scopre la pluralità persino in quell’ “unico” che è il soggetto produttore del testo. Metro polis è anche “metro/polis”: precisamente, una parola spezzata, divisa in due da una barra. E questa scissione verbale si riflette nella costruzione del libro, formato da due parti affatto identiche per estensione e speculari tra loro. In esse, l’idea di città è divisa in due: divisa in due città. Le due città sono Lan e Ziz, ovvero Milano e Palermo, rinominate con i monosillabi che sono la radice del nome (Lan per Milano), oppure il nome fondativo (il punico Ziz per Palermo). Milano e Palermo sono il Nord e il Sud, gli estremi di una Italia divisa (e che qualche dissennato “devoluzionista” vorrebbe definitivamente dividere): e sono gli ambiti di due esperienze vissute con ruoli e investimenti differenti, ma dialetticamente connesse ed entrambe gravide di contraddizioni e di lacerazioni nel tessuto dell’immaginario. Milano è la città del “centro” (quel medium che sta nell’antica denominazione di “ Mediolanum”), è il polo di attrazione del nomadismo esistenziale, è la metropoli, anzi megalopoli, dove tutto è possibile, secondo le meraviglie postmoderne; ma, nello stesso tempo, quel centro si rivela il perno di una vita senza senso e valore. È, piuttosto -così ce la mostra il testo, il luogo dell’affermarsi della pura quantizzazione monetaria nella prostituzione generalizzata («solo / carne palpa offresi in vendita / cartellino rosa in vista / su pubblica piazza»), dove impazza una grottesca “giostra” di faccendieri, furbi, improvvisati affaristi: «sono clowns / burattini prostitute giocolieri / (scommettitori d’esistenze)». E dove infine il collettivo diventa tangibile nel «corpocittà» di una massa conformista e “paludosa”, ben distante dalla armonica totalità e anzi matrice di esclusione e di rifiuto, «carnaio» amorfo che, in definitiva, coincide con un «deserto freddo / vuoto». Dall’altro lato, Palermo è lo spazio del “margine”, l’avamposto vicino al serbatoio del rimosso culturale, da cui possono emergere ancora spiriti pagani e una incontenibile “pulsione dell’anarchia” («forza orgia oscura paura / racchiusa contrasto unico / in sfida creatrice anarchia»), una forza espressiva che si fonda sul coagulo delle razze e che vede nel “meticciato” l’alternativa alla omologazione trionfante. Certamente, mentre Milano è il luogo del lavoro e della presa di coscienza, Palermo è, per l’autrice, il luogo dell’origine personale e della radice dell’infanzia e perciò l’obiettivo del ritorno e della possibilità di riconoscimento per l’«anima straniata», compreso l’uso della parola “corporea” del dialetto, legata alle funzioni primarie. Eppure, la Sicilia e il suo capoluogo sono anche il punto d’accesso a un mondo infernale dominato dall’orrore, contenendo il groppo della più feroce violenza del vivere sociale odierno, quello in cui è messo in forse il senso civile e democratico insito nella polis: lo denuncia in modo eclatante il delitto di mafia e il radicamento e la stessa possibilità del comportamento mafioso («boato d’autostrada atroce I cratere ginestre voragini / foibe falde furore a / sacromonte insiste inferno / terrifica figura con falce»). Questo percorso lungo la direttrice Milano-Palermo, questo scorciato “passaggio” tra città diverse e quasi antitetiche, non è soltanto il piano di una ricognizione geografica e storica degli sfondi e degli ambienti dell’esperienza autobiografica, è anzi la prospettiva –fortemente suggestiva nel senso dell’attualità, per mettere a fuoco i problemi dell’oggi, i fasti e nefasti delle politiche e dei poteri, le sperequazioni di uno sviluppo decisamente diseguale, le occasioni mancate degli incontri e della fusione culturale; e, nello stesso tempo, il disincanto radicale, non solo sui miti dell’avanzamento continuo e indiscriminato, ma anche sul recupero nostalgico di una identità che-nel mentre resta l’ineliminabile obiettivo di qualsiasi produzione di “senso”- è tuttavia consapevolmente irraggiungibile come salvazione consolatoria di una unità inossidabile e data una volta per tutte. Perché non ci siano equivoci: qui non si tratta né di reportage, né di memoria nostalgica, e neppure di discorso stentoreo da retorica vittimistica; la patologia urbana ci viene passo ritmico incontro nei modi e nei ritmi della immagine poetica, attraverso un linguaggio a sua volta plurale, problematico ed aperto. Nella costruzione di tale percorso, che è personale ma che, d’emblée, si fa condiviso e comune, la poesia di Antonella Doria si espone con lancinante maturità. È una scrittura che ha tolto di mezzo tutto l’inutile armamentario di abbellimenti e consolazioni, comprese le strizzatine d’occhio al saper fare tecnico o al bagaglio della tradizione, che infestano tante attività “letterarie” attuali. E ha messo da parte, insieme, anche l’autocompiacimento dell’ “io”, che ha sempre trovato nella lirica uno specchio di Narciso pronto all’uso e di facile intendimento. Qui no. Qui la poesia si manifesta come arte del “passaggio” breve (tutti
i componimenti entrano nella misura della pagina) e del che alterna “soste” a “transiti veloci”, rarefacendo le immagini, sia che le proietti in evidenza a scopo di recupero, sia che invece le proponga per una perforazione critica del loro “schermo” apparentemente invitante. In ogni caso, l’attraversamento del panorama metropolitano è altresì l’attraversamento dei simboli e delle parole che lo costituiscono e che, alla somma di tutto, ci costituiscono come urbanizzati moderni o postmoderni che si voglia. È dunque molto importante sottolineare il trattamento linguistico di questa poesia. Antonella Doria percorre i registri della lingua e dello stile in diacronia e in sincronia: da un lato, recuperando nomi e denominazioni in modo da estrarre le radici storiche impresse come impronte nel corpo della città e, in questo senso, non disdegnando affatto un linguaggio basico come il dialetto che torna nella parola degli emarginati e torna soprattutto (nella seconda sezione, quella siciliana) come stigma del proprio passato; dall’altro lato, affrontando direttamente il linguaggio depauperato odierno, sino alla formula massificata dello slogan, che viene rovesciato nella sua vacuità e però sfruttato per produrre il doppio senso di un’ironia mordente e intesa alla demistificazione. Così in «Un lavaggio candeggio / ogni giorno al cervello», dove le vantate prerogative di una lavatrice o di un detersivo si trasformano, con uno scarto
di significato, nel risultato della comunicazione consumistica: un “lavaggio del cervello”; oppure in «ho preso scarpe in rettile / borsetta in rettile / tubo tuttinrettile», dove il pregio del materiale sprigiona inopinatamente il suo potenziale metaforico a contrassegno della viscidezza e della inquietante pericolosità dell’ipocrita vantatore (o, più probabilmente, vantatrice). Fino ad arrivare al puro verbalismo della perdita di senso, che accampa il messaggio nella sua sovranità di canale comunicativo («m’affama / antenna coccodì-e-coccodà / cicci-cocco-ambarabà»), in cui diventa lampante il rumore del video-trash e in esso è stigmatizzata la perversa regola implicità: non è importante cosa si dicaanche l’insensato va bene, ma conta che il contatto venga mantenuto nel modo più continuo e costrittivo possibile. Il testo di Antonella Doria si costruisce così in un tessuto di sonorità, guidato dall’accostamento stringente della paronomasia, che si intensifica proprio all’altezza dei suoi punti nevralgici. Un esempio nella prima parte è l’accoppiamento «spasmi / miasmi», che sono le due sofferenze (rispettivamente dell’uomo e dell’ambiente) implicate nel delirio di onnipotenza della grande città, «torre d’infinita / Babele». Un altro esempio, nella seconda parte, potrebbe partire dalla «ameba umida» (e P«ameba» – quel vecchio protozoo- è davvero perfetta a rappresentare i movimenti scoordinati e le contorsioni e le scissioni della ideologia elementare dei nostri “tempi nuovi”) e passare poi per la «vischiosa ventosa» e i «visceri viscidi», e poi ancora nel «si protende pròteo / propàgine piegata piagata», per giungere a «fiele filtra / da abissiabili» (una abilità dell’abisso”: sarà mica la valenza solidamente pragmatica di ogni evanescente e pretenzioso misticismo?). In questi testi, il gioco con il corpo della parola è tutt’altro che innocente; è, invece, estremamente tendenzioso. Tanto per dirne uno, è bellissimo – e assolutamente “no-global” – il «pappamondo» (indice della voracità indifferenziata dell’accumulazione capitalistica). Pure molto efficace è il passo in cui (proprio nell’ultimo brano della parte “milanese”) dovrebbe essere enunciato l’imperativo alla solidarietà, non fosse che il comandamento evangelico ad amarsi” si impiccia e si contorce in: «a morsi a morsi / amarsi»; come a dire che l’amore del prossimo o si deforma in una contraria aggressività (con “morsi” al posto dei baci), oppure, quand’anche venga affermato, contiene in sé – quella lettera in paren- tesi ha il ruolo di un inconscio del linguaggio, l’elemento deteriorante di una probabile interferenza proditoria. Ma il tratto stilistico che più mi ha colpito, in questa Metro polis, è di natura sintattica: è la vocazione all’accostamento elencativo dei termini, con minimo ricorso all’articolo, quasi che si volesse sprigionare da ogni singola parola tutta la sua carica semantica per giocarla poi nei Ti
il rapporti che si creano nella concatenazione degli elementi. È i principio metaforico, per cui una parola ne fa conoscere un’altra, si esplicasse attraverso il principio metonimico che fa valere la contiguità, il transfert e il contagio dei significati. La sequenza, privata degli ordinari collegamenti grammaticali, perde di ordine gerarchico e si affolla invece in “frammenti” di immagini, ciascuno dei quali porta la sua pietruzza al mosaico: «Transita / la mente attraversamenti / veloci sotterranei percorsi / di vuoto silenziosa ombra / sul collo il fiato la voce / diffonde respira…»; e si veda: «questa / voglia estrema tenera / eterea favella favilla / balena sotto la morta / brace bagliori di pelle / vene corde appese / di fuoco lingue alleva», per comprendere quanto il ritmo di “unità semantiche” consenta di far crescere per molteplici spunti il correlato tra il fuoco (che è anche la pulsione repressa che “cova sotto la cenere”) e il linguaggio, uniti attraverso le diverse figure della paronomasia («favella favilla») e della reviviscenza della locuzione comune (le “lingue di fuoco”). Successione incalzante, accumulazione di parole che sembra prediligere il verso di tre membri, ma talvolta aumentandolo a quattro e in qualche caso diminuendo di numero, questo procedimento di “sommatoria verbale” attiva insieme il livello sonoro e quello concettuale della comunicazione poetica. Si veda ancora questo passo che va calando, fino a una sola, la quantità di parole nel verso: «degradazione di luce distanza dilata / rischio a perdersi in giri volute
grate sagrati inferiate forme / fondali tonde prospettive / scenografie surreali / insensate» – è un passo che sembra sottolineare, se lo interpreto bene, il “rischio” dell’estetica e della logica puramente artistica, che nasconde, come in un bel “fondale”, motivi di oppressione (si noti il gioco di parole sulla “gradazione” luminosa trasposta in «degradazione»; e si segua la spia della paronomasia tra “grate” e “sagrati”: sacralità e di vieto). E l’insieme caotico in incalzante successione: «ma niente turbi | sonno sogno cecità veggenza mistico Sabisso azzardi deliri 7 diversi corsi corpi di fervori armonie / massacri insegue insegne silenzi», dove il flusso dell’elencazione porta con sé la contrarietà dell’ossimoro (del tipo «cecità veggenza») e la pausa dell’enjambement fa di tutto per tehere separati –mentre in sostanza li accavalla, rilevandone così la giunzione, gli incompatibili sensi di «armonie» e «massacri». Ecco che, allora, l’immagine poetica non si accampa con l’autoritaria affermazione di un solo simbolo portante, ma si ottiene dalla conside razione pezzo-per-pezzo di una serie di passaggi e di suggerimenti allusivi: per quanto Antonella Doria non si esima per nulla dal pronunciare esplicite dichiarazioni di intenti, come quel richiamo a «poesia passione rivoluzione, che si trova a un passo dalla fine del libro, nondimeno – anzi proprio in dipendenza da una simile intenzione non-conformista – la sua è una immagine composita e plurale, una “costellazione” di segni e di segnali, un testo fatto di «parole oblique» che compongono un messaggio tendente in più direzioni, per sua natura dialettico, come è dialettica la struttura bipartita della raccolta. A scorno della patologia dell’uno, c’è sempre il due: due razze come due genitori, quindi due patrie, due principi; e due città. La parola stessa non significa soltanto in qualità di arricchimento semantico, ma anche come tentativo di espressione al di là del codice: in questo suo aspetto la parola sconfina nel silenzio – dall’inizio («luoghi / affiorano di transiti / d’ascolto in silenzi stasi») alla fine («silenzio parole passi»: è il penultimo verso del testo nel suo complesso); – dunque, la parola è sempre duplice. È “transito” e “sosta”, passaggio del senso: è pieno e vuoto, istanza di adempimento e espulsione di rifiuto. Citavo il penultimo verso; e aggiungerei anche l’ultimo, che è: «(mi) porta» – gioco, ancora una volta assai tendenzioso, tra verbo e sostantivo, tra il “lasciarsi portare” che il viaggio-passaggio sempre implica e la “porta” come punto del passaggio, connotato dall’ambiguità e dalla doppiezza della sua apertura. E proprio in questo carattere “aperto”, dialettico e plurale che la poesia traccia il suo provvisorio passare. E per questo che procede, come abbiamo visto, una parola dietro l’altra, mettendo in “fila” i suoi termini, come i passi progressivi di un cammino; e non a caso tenendo presente il modello della filastrocca («ripete ritorna fila strofa / canti lena antica nenia»; sempre nel finale). Nessuna parola basta, come nessuna città: il passaggio è sempre in movimento. Con questa sua dinamica, che ha qualcosa di produttivamente utopico, la poesia prende posizione contro le chiusure del presente, contro i nuovi confini, i gretti localismi, le ostentate difese del privilegio.
a Maria mia
madreterra (alla
terra)
2
Lacittàsidispiega
ilsuovoltoèilvoltodel
[mioamore
lesuegambesonogambedi
……
quiiltempofinisce iniziaqui
OctavioPaz
[donna
3
Lan
4
5
Con il mento sulle mani, dal
[l’alto della mia mansarda, Vedrò l’officina che canta e
[chiacchiera, Le ciminiere, icampanili, alberi
[della nave-città, E i grandi cieli che fan sognare
[d’eternità. Charles Baudelaire
Proemio
Celti raminghi sulla tua pianura
segnano solchi quadrati prima
di mezzo in cerchio il centro
terra di marcite d’acque
innalzano deliri solitari
chiostri di perdizione salvezza
austeri poveri borghi
castelli medievali cattedrali
(per grandi peccatori ) e
grattacieli alti
Di molte acque in cerchio Città
perla anello nasce
colta da duchi longobardi
Curtis ducis il Centro di
Milano
6
*
A margine del caso
serve un riparo di vento necessità e salvezza terre sospese versodove abitare a volte
l’ordine nomade sente l’ombra sentore di quiete pagana profana omni potenza torre d’infinita Babele
a margine del caso
a volte
con il cielo azzurro
il vortice procede
paghi prezzi spasmi miasmi gozzovigliati in abissi reiterato dramma di parola erosa legata lingua al vuoto impossibile dire esprimere un’altra storia
+ STELLA . PARIT. SOLEM .ROSA .FLOREM.FORMA . DECOREM +
Cappella Palatina XI sec.
Prologo
Cháos Kósmos Contrasto di Cielo
alto sfida sublime suona forma
meticcia musaico impasto spazio
tempo apre l’orda di venti pirati
contro centro unico ( inghiottiva
il mondo… ) da quattro canti
in corso incontri cammino spaziano
nuove orme stagioni stazioni
nei molti attraversamenti…
d’affanno lume superbo soste schegge
lungimiranti in vista d’orizzonti
feritoie forme profili ideali
d’abituale marea ripensamenti
Emerge scenico spazio figura
personaggio parvenza pura perenne
ricerca ragionedelirio – verità sua
a ciascuno abbiamo in tasca…
34
*
(nóstos)
Dicono che qui, fra splen dore
e squallore, non rimanga
spazioper il soave;
(…) / Dicono…
Gesualdo Bufalino
A margine del tempo
immerso a’ vapori sfumanti
in verde improvvisa
irrompe la torma moresca dei venti
(riannoda funi sommerse)
la nave il ponte il quadro
a l’orizzonte miraggio djebel
alto di rocciacorona ( paradiso
bolgia ) a’ la Cala
a’ la Catena viene vaga viòla
onda bruma umida luce mattino
d’iride residuo puzzo piscio alga
nafta umori conosco (mi)riconosco
tempo di muti mutevoli bagliori buio
segreto barocco conosco il canto
il falco la forzatura
frutto acerbo cedro lunare
verdello la piega il passo il segno
saggio indolente in questa
spanna invisibile sonnolenta
distratta eterna lotta annega
in mare di terra ragioni
religioni il verde cupo
di aranci limoni
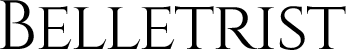
Lascia un commento